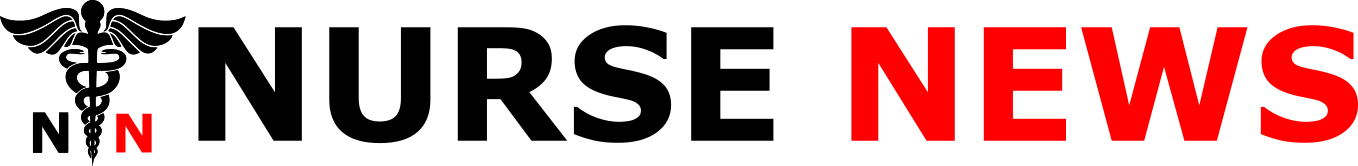Cassazione Civile, Sez. Lav., 17 aprile 2019, n. 10725 – C
Nel verificare la situazione, si noti che con una sentenza datata 13 marzo 2017, la Corte d’appello di Milano respingeva l’appello presentato da DM Logistica s.r.l. contro le sentenze del Tribunale di Pavia, specificamente la sentenza non definitiva (n. 284/2016) e la sentenza definitiva (n. 387/2016). Queste sentenze avevano stabilito il diritto di A. M. a essere collocata nel II livello del CCNL di categoria, dichiarando illegittimo il suo licenziamento, avvenuto il 23 agosto 2011, a causa della violazione del periodo di comporto. La società datrice era stata condannata a versare una somma di € 41.043,00 a titolo di risarcimento per mobbing, oltre agli interessi legali (con riferimento alla prima sentenza), nonché le somme di € 5.000,00 come differenze retributive per il superiore inquadramento riconosciuto e di € 8.384,88 per indennità derivante dal licenziamento illegittimo (con riferimento alla seconda sentenza).
La società datrice ha presentato un ricorso in cassazione contro la suddetta sentenza, motivandolo con dieci ragioni specifiche. In risposta, la lavoratrice ha presentato un controricorso e una memoria ai sensi dell’art. 3800bisl c.p.c. per opporsi al ricorso della società.
L’argomentazione del ricorso in cassazione presentata dalla società datrice può apparire apparente e contraddittoria. Questo deriva da un’erronea valutazione del danno dovuta all’argomentazione “per relationem” alla C.t.u. medico-legale. In particolare, si è basata su una valutazione di comportamenti illeciti (volontà mobbizzante) diversi da quelli stabiliti dalla Corte d’appello, che aveva invece riconosciuto singoli comportamenti colposi da parte del datore di lavoro (ottavo motivo). Inoltre, è stato omesso l’esame di un fatto cruciale oggetto di dibattito tra le parti: l’occasionalità delle mansioni svolte dalla lavoratrice, come evidenziato dalle prove raccolte, che avrebbero potuto costituire indicatori negativi per l’assegnazione di mansioni superiori (nono motivo). Infine, si è sostenuta una falsa applicazione dell’art. 16 del CCNL di settore, poiché la previsione di assegnazione del superiore inquadramento al lavoratore per mansioni diverse, quando svolte con continuità, è stata ritenuta inapplicabile in questo caso, sulla base delle prove raccolte (decimo motivo).
che il collegio ritiene che i primi due motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, siano infondati;
che secondo consolidati principi di diritto, il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa: in un’ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è tuttavia necessario che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive (Cass. 29 ottobre 2018, n. 27392); che il lavoratore deve comunque presentare la richiesta di fruizione delle ferie, affinché il datore di lavoro gli possa concedere di beneficiarne durante il periodo di malattia, valutando il fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto di lavoro (Cass. 27 febbraio 2003, n. 3028; Cass. 27 ottobre 2014, n. 22753): e la richiesta deve contenere l’indicazione del momento a decorrere dal quale egli intende ottenere la conversione del titolo dell’assenza, che deve precedere la scadenza del periodo di comporto, dato che al momento di detta scadenza il datore di lavoro acquisisce il diritto di recedere ai sensi dell’art. 2110 c.c. (Cass. 11 maggio 2000, n. 6043; Cass. 5 aprile 2017, n. 8834);
che in tali casi si deve escludere una incompatibilità assoluta tra ferie e malattia, perché non sarebbe costituzionalmente corretto precludere il diritto alle ferie in ragione delle condizioni psico-fisiche inidonee al loro pieno godimento (non potendo operare, a causa della probabile perdita del posto di lavoro conseguente al superamento del comporto, il criterio della sospensione delle stesse e del loro spostamento al termine della malattia), posto che si renderebbe altrimenti impossibile l’effettiva fruizione delle ferie; spettando poi al datore di lavoro, cui è generalmente riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie, di dimostrare (ove sia stato investito di tale richiesta) di aver tenuto conto, nell’assumere la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto (Cass. 19 novembre 1998, n. 11691; Cass. 3 marzo 2009, n. 5078);
che la Corte territoriale ha correttamente applicato tali principi (richiamati al terzo e quarto capoverso di pg. 8 della sentenza) ed ha accertato in fatto l’avvenuta presentazione della tempestiva richiesta di ferie dalla lavoratrice prima della scadenza del periodo di comporto (correttamente ritenendo non essere necessario, alla luce dei suenunciati principi di diritto, che ciò si verifichi proprio nella sua imminenza: così al sesto capoverso di pg. 8 della sentenza), respinta dalla società datrice senza offrire alcuna prova delle esigenze aziendali a giustificazione del rifiuto, né tanto meno la loro prevalenza rispetto all’interesse della dipendente alla conservazione del posto (al primo e quinto capoverso di pg. 8 della sentenza): con valutazione riservata al giudice di merito, congruamente argomentata e pertanto incensurabile in sede di legittimità; che parimenti insindacabile è la valutazione di idoneità della richiesta di ferie della lavoratrice (indicata dalla Corte milanese nel documento prodotto sub 12 nel suo fascicolo di primo grado: così al primo capoverso di pg. 8 della sentenza), in assenza di indicazione dei canoni ermeneutici violati (Cass. 14 giugno 2006, n. 13717; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350), avendo la ricorrente contestato il risultato interpretativo in sé (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891), per una mera contrapposizione della propria interpretazione di parte (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197);
che, ancor prima, occorre rilevare il profilo di violazione del principio di specificità prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., relativo alla mancata trascrizione del testo della lettera di richiesta oggetto di doglianza, che ne preclude una valutazione diretta a questa Corte (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915, con affermazione del principio ai sensi dell’art. 360bis, primo comma c.p.c.; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48);
che i motivi dal terzo all’ottavo, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;
che occorre premettere l’inammissibilità del profilo dei motivi (esplicitamente il quarto, ma sostanzialmente anche gli altri addirittura neppure configuranti la più circoscritta ipotesi di devoluzione del vizio motivo nella rimodulazione del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.) di omesso esame di un fatto storico, per l’integrazione dell’ipotesi di cd. “doppia conforme” prevista dall’art. 348ter, quinto comma c.p.c., applicabile, ai sensi dell’art. 54, secondo comma d.l. 83/2012 conv. con modif. dalla I. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 (nel caso di specie in data 4 novembre 2016);
che la parte ricorrente non ha infatti indicato, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità (Cass. 10 marzo 2014, n. 5528; Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 14 novembre 2018, n. 29369); che in ogni caso neppure si tratta di omesso esame di fatti storici, ma piuttosto di documenti da utilizzare in funzione di una valutazione probatoria oggetto di contestazione ovvero di contestazione di valutazione probatoria tout court (pertanto al di fuori dell’ambito devolutivo della disposizione novellata: Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);
che ricorre poi un essenziale equivoco in ordine alla diversità, invero insussistente, della condotta datoriale assunta a fondamento della condanna risarcitoria, in favore della lavoratrice da parte della Corte territoriale, in base ad una responsabilità colposa in violazione dell’art. 2087 c.c. asseritamente “altra” dalla volontà mobbizzante dolosa riferita all’accertamento del Tribunale;
che in realtà essa si è esplicata nei medesimi comportamenti datoriali (di continue e pressanti richieste di chiarimenti alla lavoratrice sulle sue assenze per malattia e sulle cure mediche, di privazione della parte più rilevante delle mansioni al rientro dalla malattia, di richiesta di dimissioni rifiutata dalla medesima) emersi dall’istruzione testimoniale e confermati dalla C.t.u. esperita, condivisi nella valutazione di illiceità da entrambi i giudici di merito (come evidente al primo capoverso di pg. 9 e al primo di pg. 12 della sentenza);
che essi sono stati apprezzati alla stregua di condotte vessatorie integranti mobbing anche dalla Corte territoriale, come evidente dai condivisi arresti giurisprudenziali citati e riconducibili a responsabilità datoriale a norma dell’art. 2087 c.c. (così dall’ultimo capoverso di pg. 10 al primo di pg. 11 della sentenza); che una tale riconducilità è coerente con i consolidati principi di diritto affermati in sede di legittimità per cui, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, l’elemento qualificante, che deve essere provato da chi assuma di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell’illegittimità dei singoli atti bensì nell’intento persecutorio che li unifica: sicché la legittimità dei provvedimenti può rilevare indirettamente perché, in difetto di elementi probatori di segno contrario, sintomatica dell’assenza dell’elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta, unitariamente considerata (Cass. 10 novembre 2017, n. 26684; Cass. 21 maggio 2018, n. 12437); che pertanto la responsabilità per mobbing deve essere, come è, inquadrata nel’ambito applicativo dell’art. 2087 c.c., in quanto ricollegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (Cass. 29 gennaio 2013, n, 2038; Cass. 5 novembre 2012, n. 18927; Cass. 3 marzo 2016, n. 4222): siccome in violazione dell’obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dal citato art. 2087 c.c. (Cass. 9 settembre 2008, n. 22858; Cass. 25 luglio 2013, n. 18093); che la chiarita inesistenza di alcuna diversa qualificazione del comportamento datoriale riflette conseguenti effetti di infondatezza sul settimo e ottavo motivo motivo, per il coerente e chiaramente argomentato accertamento, anche per relationem alla C.t.u. (ben possibile nella esplicita condivisione della Corte territoriale), del nesso eziologico tra comportamento e danno (all’ultimo capoverso di pg. 11 e al primo periodo di pg. 12 della sentenza) e della liquidazione di quest’ultimo (per le ragioni esposte dal terzo al penultimo capoverso di pg. 12 della sentenza);
che ¡l nono e il decimo motivo, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;
che occorre premettere anche qui, per le ragioni già illustrate, l’inammissibilità dell’omesso esame denunciato in presenza di un accertamento con cd. “doppia conforme ” (come risulta evidente dalla lettura del secondo capoverso di pg. 3 e del terzultimo di pg. 6 della sentenza), neppure sussistendo alcuna omissione di un fatto storico, ma piuttosto la contestazione di una valutazione probatoria e della sollecitazione sostanziale di un suo riesame nel merito, evidentemente eccedente i limiti di sindacato in sede di legittimità;
che non si configura poi una violazione della norma collettiva denunciata, tra l’altro in assenza di una specifica indicazione della produzione del CCNL, neppure risultante, nel proprio (e non nell’altrui) fascicolo di parte, né di trascrizione della norma medesima; che una corretta deduzione del vizio di violazione di legge (cui è parificata sul piano processuale quella di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, anch’essa comportando, in sede di legittimità, l’interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale, ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c., come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione: Cass. 19 marzo 2014, n. 6335; Cass. 9 settembre 2014, n. 18946; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24036; Cass. 28 settembre 2018, n. 23609) consiste, infatti, nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, necessariamente implicante un problema interpretativo della stessa, non mediato dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, riservata alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24054);
che i due motivi si risolvono così nella contestazione di un accertamento in fatto, correttamente svolto e congruamente argomentato dalla Corte territoriale (per le ragioni esposte dal terzultimo capoverso di pg. 6 al quart’ultimo di pg. 7 della sentenza);
che essa ha osservato, nel giudizio relativo all’attribuzione di una qualifica superiore, il cd. criterio “trifasico”, da cui non si può prescindere nel procedimento logicogiuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento del lavoratore (Cass. 27 settembre 2010, n. 20272; Cass. 28 aprile 2015, n. 8589; Cass. 27 settembre 2016, n. 18943), di competenza esclusiva del giudice di merito;
che la Corte meneghina ha pure compiuto una corretta indagine (necessaria qualora la contrattazione collettiva preveda, nel disciplinare la classificazione dei lavoratori, sia le categorie o livelli, mediante declaratorie astratte e generali, sia distinti e specifici profili professionali), al fine di determinare la qualifica spettante alla lavoratrice, consistente nella verifica di corrispondenza delle mansioni in concreto svolte a quelle di un determinato profilo professionale indicato dalla stessa contrattazione collettiva come rientrante in una particolare categoria: che è pure accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità ove correttamente e congruamente motivato (Cass. 7 luglio 2004, n. 12513);
che pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese di giudizio, secondo il regime di soccombenza, senza condanna risarcitoria ai sensi dell’art. 96 c.p.c. per lite temeraria, non ricorrendo i presupposti di abuso della potestas agendi per un’utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, a fini diversi da quelli cui esso è preordinato e produttivo di effetti pregiudizievoli per la controparte (Cass. s.u. 13 settembre 2018, n. 22405);
che ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato come da dispositivo;
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Redazione NurseNews.eu
Fonte
Olimpus.uniurb.it